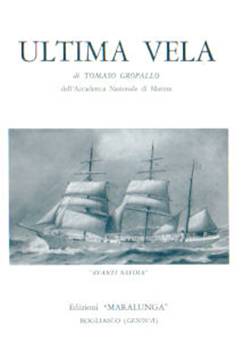La marineria velica di lungo corso
Un’epopea dimenticata
Nessun
marinaio, dopo il suo turno di guardia trascorso in massacrante lavoro, si
butta a dormire tanto stanco da non togliersi i vestiti bagnati fradici per
venir magari, poco dopo, richiamato in coperta per improvvise emergenze perdendo
preziose ore di sonno; nessun marinaio, dopo pochi giorni di navigazione in
alto mare, mangia solo carne salata e galletta infestata dai parassiti con il
rischio dello scorbuto; nessuno beve acqua rigorosamente razionata e per di più
andata a male; nessuno viene a trovarsi in posizione di rischiare la vita in
alto su alberi oscillanti, pennoni scivolosi e vele gonfie di tempesta
manovrandole proprio per salvarsi la vita; nessuno si presta ai faticosi lavori
di carico e scarico propri delle compagnie portuali o agli impegnativi lavori
di raddobbo da cantiere richiesti all’equipaggio per risparmiare le relative
spese; nessuno passa mesi e mesi lontano da terra con intorno soltanto sconfinate
distese di cielo e di mare troppo spesso imbronciate quando non burrascose;
nessuno è pagato tanto poco per fare una vita tanto irta di pericoli, stenti e
sacrifici. Non al giorno d’oggi.
Eppure
qualcuno c’è stato in un passato non tanto lontano, anzi più d’uno. Erano i
marinai di una volta, quelli dei velieri di lungo corso, del Capo Horn, una
razza marina che si stenta a credere sia esistita ed abbia potuto resistere a
situazioni del genere. Non per niente un antico detto recitava che gli uomini
si dividevano in tre categorie: i vivi, i morti e coloro che andavano per mare.
Una razza scontrosa e fedele, vigorosa e fiera — ha detto Joseph Conrad —
capace di ogni rinuncia e dedizione, con i suoi riti, i suoi usi, il suo
coraggio. Uomini che il mare lo conoscevano per davvero perché vivevano ed
operavano a contatto diretto con esso, con i suoi capricci, con le sue
apparenti blandizie, con le sue violenze, con le brezze o con le bufere lungo
gli inevitabili “Quaranta ruggenti” e i “Cinquanta urlanti” delle latitudini
oceaniche australi che alzavano ondate montagnose e dirompenti che salivano in
coperta sotto cieli percorsi da minacciose nubi plumbee scioglientisi in
pioggia battente, grandine martellante e nevischio. Oppure nelle calme
equatoriali piatte e senza un filo di vento, parimenti disperanti. Il tutto
senza alcun presidio sanitario, senza possibilità di cure in caso di malattia,
che in certe zone poteva essere il beri-beri o la febbre gialla (ma anche
l’influenza “spagnola” del 1918), dovendo inoltre fare i conti con i topi, gli
scarafaggi, le cimici e perfino con le zanzare. Ineluttabili i fattori tecnici
e umani con un complesso di attività fortemente condizionate dall’ambiente e
senza un momento di requie. Grande la fatica fisica, grande la sofferenza,
grandi i pericoli. Navigazione condotta in alto mare con rara abilità sulla
sola base di calcoli astronomici o stimati, senza possibilità di verifiche
offerte dai punti salienti di terra, col solo aiuto del sestante, del prezioso
cronometro, di una bussola di dubbia compensazione, del barometro e nulla più.
Un’arte sorretta da esperienze incredibili, da intuizioni e da colpi di
fortuna.
Non
sarà mai abbastanza riconosciuto quanto merito, a beneficio del progresso e
della civiltà affermatasi tra la seconda metà del 1800 e i primi decenni del
La
vita di bordo seguiva rigorose regole integrate immancabilmente da tradizioni
osservate spontaneamente con rigore secondo una gerarchia al vertice della
quale stava il capitano, detto comunemente “il vecchio” (the old man) anche se uomo giovane, e mai chiamato comandante
(termine, questo, divenuto proprio della marina a vapore), coadiuvato da un
primo ufficiale (Chief o First Mate) con compiti di
vicecomandante, e da un secondo e terzo ufficiale (per lo più capitani di lungo
corso patentati ma non abilitati) con residenza sul casseretto di poppa.
L’equipaggio era formato dal nostromo, figura centrica, dal cuoco, dal
carpentiere (in epoca più antica anche dal bottaio) e dal velaio, mansione
importante la sua in quanto non era difficile perdere le vele fatte a brandelli
dalle raffiche degli uragani e quindi da sostituire con vele da lui
confezionate, tutti col grado di sottufficiale con una propria cabina, esenti
dai turni di guardia, e infine dai marinai: mozzi giovanissimi, giovinotti
(giovani marinai non ancora riconosciuti), pilotini, marinai, nocchieri e gabbieri
più o meno sperimentati ma affiatati come necessaria conseguenza dei comuni
pericoli affrontati e da affrontare, che stavano a proravia dell’albero maestro
in un alloggio comune, divisi in due guardie alternate di quattro in quattro
ore (con una guardia di due ore, alternante), dette destrale e sinistrale. Una
categoria a parte era formata dagli allievi, immancabili sui velieri
specialmente inglesi, destinati a divenire capitani patentati ma impegnati, a
bordo, nei turni e nei servizi dei marinai secondo una scuola molto dura di
pratica. Nei momenti di emergenza, che non erano rari, tutti erano chiamati
alle manovre e salivano sulle alberature, altissime e oscillanti, anche i
sottufficiali cuoco compreso e gli ufficiali. Molto apprezzato era allora il misurino
di rhum distribuito alla gente al termine di una manovra impegnativa o eseguita
sotto l’imperversare della burrasca, o altra avventura del genere. Qualche
aiuto era subentrato negli ultimi anni grazie all’irrobustimento delle
alberature e delle manovre fisse e correnti, ai cavi d’acciaio e catena, alla
calderina ausiliaria a vapore ed alla manovra di orientamento dei pennoni per
mezzo di particolari verricelli (la cui prima applicazione si doveva allo
scozzese J.C.B. Jarvis ma non subito presa in considerazione da tutti gli
armatori). Subentravano miglioramenti anche in fatto di viveri con la carne in
scatola (non molto migliore, però, della carne salata in barile), stoccafisso,
pane fresco la domenica, fagioli e piselli secchi e simili. Un po’ di carne
fresca poteva essere procurato a volte grazie alla cattura di qualche focena o
di qualche delfino e allora era una festa. Migliorava anche la situazione
dell’acqua con l’introduzione di cisterne metalliche zincate, ma sempre
razionata, per cui veniva continuata con cura la raccolta dell’acqua piovana.
Fatto curioso era che a bordo non esisteva denaro circolante, che la moneta
quale sia stata non aveva corso. C’era però la possibilità di fare qualche
acquisto utile, ad esempio vestiario, sapone, scatole di marmellata da una
specie di cooperativa interna sotto la diretta sorveglianza del capitano, che
poteva concedere qualche giustificato anticipo sulle spettanze maturate da
ciascun uomo, ufficiale, sottufficiale o marinaio, che venivano liquidate alla
fine di ciascun viaggio. L’arruolamento degli equipaggi avveniva in linea di
massima per viaggio o per campagna secondo regole ed usi nazionali, propri di
ciascuna bandiera, per cui gli inglesi imbarcavano gente di ogni paese e di
ogni lingua con la conseguenza che, a bordo, veniva a formarsi non di rado un
singolare cosmopolitismo temporaneo; gli americani, dopo aver preparata la
nave alla partenza, imbarcavano l’equipaggio di bassa forza, gente di ogni
risma, all’ultimo momento; i francesi si avvalevano il più possibile di certi
ruoli nazionali di qualifica; i tedeschi imbarcavano solo connazionali con
l’obbligo di sbarcare a fine campagna soltanto nei porti tedeschi condannando
le diserzioni; gli italiani preferivano i connazionali e gli stranieri imbarcati
erano pochi.
Si
giungeva così all’ultimo periodo di un’attività che il progresso stava
rapidamente eliminando.
Le
distese oceaniche aperte erano segnate da regimi di venti regolari permanenti
o stagionali (alisei e monsoni) perché non deviati dalle formazioni geologiche
continentali, però sconvolti spesso da tempeste e uragani di grande violenza,
specialmente nelle basse latitudini australi, dominio dei citati “Quaranta
ruggenti” e dei “Cinquanta urlanti”, con mare insidiato inoltre dai ghiacci
vaganti. Bisognava tener conto, inoltre, delle correnti marine, delle zone di
calma completa per cui le rotte seguite dai velieri non erano rettilinee, come
sembrerebbe possibile osservando una carta geografica, e variavano anche
secondo le stagioni in base alle esperienze di ciascun capitano. Ogni capitano
faceva tesoro delle sue conoscenze ma s’era pensato di pubblicare anche delle
carte informative, a cominciare da quelle stese nel 1850 dall’americano Maury
via via perfezionate fino alle attuali “pilot
chartes” annuali. Il punto cruciale era rappresentato dal passaggio del
leggendario Capo Horn, sconvolto dalle tempeste quasi in continuità per cui
quella zona di mare segnava il naufragio di numerose navi sfortunate tra quelle
che erano obbligate a doppiarlo se volevano passare dall’Atlantico al Pacifico,
col vento che in quella zona dominava di prua, tanto da trovarsi ricacciate
indietro più volte con equipaggi stremati e bagnati per giorni e giorni
dall’acqua gelida che rompeva da tutte le parti. Si cita ad esempio il caso del
veliero inglese “British Isles”, capitano James Platt Barker, che risulta
essere stato il più provato con manovre e rischi incredibili, avanti e
indietro, con in più un focolaio d’incendio per autocombustione del carico di
carbone, ma riuscendo testardamente a passare con perdita di uomini e vistosi
danni all’alberatura, essendo incappato nel 1905 nella peggiore serie di
burrasche che avesse mai flagellato la zona, danni gravi che egli riparava in
proprio con grande perizia professionale.
L’attività
riguardava quanto rimaneva dei trasporti di massa, guano cileno, salnitro
peruviano, carbone europeo o australiano, grano americano, minerali di nickel
neocaledonesi , lana australiana, petrolio in cassette, legname, pesce in
scatola dell’Alaska. E, al tempo della corsa all’oro californiano, anche
passeggeri della costa orientale in cerca di ventura, sempre via Capo Horn.
Finché l’apertura del Canale di Panama (1914) provocava alla vela ulteriori
perdite operative. Non era facile trovare carichi da trasportare nonostante i
noli tirati al minimo, ed i velieri facevano talora parte del viaggio in
zavorra pur di lavorare restando magari inoperosi per dei mesi in porti che
imponevano turni di carico o per scioperi interminabili come lo sciopero dei minatori
avvenuto in Australia nel 1906.
Gli
affari stavano passando intanto ai piroscafi, sempre più affidabili ed
economici, che, non dipendendo dai capricci del vento, assicuravano consegne
più regolari secondo precisi impegni di noleggio. Concorrenti che i velieri non
riuscirono più a contrastare.
Tutto
ciò ha alimentato una nutrita memorialistica, una letteratura di vita vissuta
che ha oggi il sapore della saga, dell’epopea, con testimonianze fotografiche
che confermano pagine che altrimenti sembrerebbero intessute di esagerazioni
letterarie.
GLI EAST INDIAMEN
L’Inghilterra
comunicava con il suo grande impero d’India esclusivamente per via marittima e
perciò abbisognava non solo di navi ma di navi che fossero adatte al trasporto
sia di uomini che di cose.
La
potente Compagnia Inglese delle Indie Orientali dominava incontrastata con una
sua flotta di velieri noti come East Indiamen molto simili alle navi da guerra
del tempo, però con sistemazioni anche per passeggeri di classe. Navi comode
grazie alla carena di forme piene, ma che avevano il difetto di essere lente,
scarse di manovrabilità e di obbedienza al vento sicché i viaggi erano
interminabili.
I CLIPPER
Mutavano
i tempi dopo le guerre napoleoniche, che avevano visto in azione navi corsare
capaci di sviluppare velocità imbattibili, mutavano anche le esigenze
economiche ed operative del mondo occidentale.
Nasceva
così, intorno al 1820, un nuovo tipo di veliero che tradizionalmente si pone
nelle coste nordorientali degli Stati Uniti d’America, nazione giovane e dinamica
ben diversa dal mondo conservatore e consuetudinario inglese. Trattavasi di una
nave ancora piccola, a due alberi, detta BALTIMORE CLIPPER perché nata a
Baltimora, caratterizzata da forme di scafo molto stellate e molta vela, agile,
manovriera e sopra tutto veloce. Buona pertanto al contrabbando e al trasporto
di schiavi, perfino pirata. Secondo fonti più credibili, il primo vero clipper
, quantomeno a farsi notare, sarebbe stato l’ “Ann Mac Kim” del 1832,
stazzante 493 tonn., con carena rivestita di rame. Nel 1840 ed anni successivi
si trovavano in esercizio non pochi velieri di questo tipo, più grandi,
progettati da architetti assai reputati quali Donald Mac Kay, George Thomas e
John Griffits. Basti citare il “Great Republic”, il “Dreadnought”, il
“Lightning”. Sulla scia degli Americani si mettevano gli Inglesi, o meglio
Scozzesi, col capostipite “Scottish Maid” seguito da molte unità eccellenti
tanto da declassare quelle americane. Alla fine degli anni cinquanta John
Jordan introduceva la costruzione degli scafi composita, con ordinate in
metallo, irrobustendo e nello stesso alleggerendo una struttura nata alquanto
debole. Col “Richard Cobden” veniva sperimentato nel 1844 il primo veliero di
ferro. Il capitano inglese William Clinfton sperimentava anche la navigazione
contro il monsone dando il via alle complessa attrezzatura velica propria dei
velieri veloci, ricorrendo perfino all’aiuto dei rimorchiatori a vapore per
lunghi tratti al fine di guadagnare cammino.
Prendeva
piede, così, il tipo generico del CLIPPER (nome derivante, forse, dal cavallo
da corsa degli stati americani sudisti) che, acquistando maggiore stazza tra il
1830 e il 1860, si divideva in più sottotipi sia americani che inglesi.
OPIUM CLIPPER
L’uso
dell’oppio si diffondeva in Cina come coadiuvante alla fatica e alla povertà
dell’alimentazione specie nei vasti territori malsani costieri. Ma il consumo
individuale veniva ad aumentare sempre più con gravi avvelenamenti e con
effetti sociali negativi tanto che il governo del Celeste Impero ne proibiva il
consumo, incrementato egoisticamente con alti guadagni da commercianti
americani, inglesi e francesi, senza riuscire tuttavia nell’intento. Si
arrivava così ad atti di forza ed alle due guerre dette “dell’oppio” (1842 e
1857) combattute dall’Inghilterra e dalla Francia a seguito delle quali
Finiva
per imporsi anche in queste acque la navigazione a vapore, più sicura e
controllabile, la lucrosa attività di contrabbando cessava ma il clipper
restava.
IL TEA CLIPPER E IL “CUTTY
SARK”
L’uso
del tè ha avuto, in Cina, grande diffusione fin dai tempi più antichi
estendendosi dalle rive del Mar Giallo in tutto l’impero con un infuso che
intendeva correggere la fangosa e malsana acqua dei fiumi. Se ne sentiva a
parlare in Europa già nel 1500 come panacea, ma è nel 1600 che arrivano
quantità ragguardevoli da Macao per opera degli Olandesi. Con la fine della
guerra dell’oppio del 1842 cominciavano le regolari esportazioni in Occidente,
ed erano gli Americani a portare inizialmente il tè in Inghilterra facendosi
attivissimi sulla piazza di Londra.
Il “Cutty Sark” è il celebre veliero veloce
(dal curioso nome che significa “corta camicciola” tratto dai versi di un poeta
scozzese) sinonimo del clipper, attualmente conservato a secco nel bacino di
Greenwich, realizzato dalla Cutty Sark Preservation Society nel 1959 dopo un
accurato ripristino, conosciuto generalmente anche grazie alla reclamizzazione
di molti prodotti industriali moderni.
Costruito
con la massima cura su progetto dell’architetto Hercules Linton e varato nella
Clyde nel 1869 per conto del facoltoso armatore scozzese John Willis
(conservatore ad oltranza in fatto di marineria velica, detto Withe Hat per il
cappello bianco che usava portare), il quale lo tenne fino al 1895 quando lo
vendeva ad armatori portoghesi, che lo impiegavano fino al 1922 col nome di
“Ferreira”. Tornava sotto bandiera inglese per venire ripristinato come cimelio
di un tipo straordinario di veliero, degno di ogni considerazione, impiegato in
traffici specializzati, testimone autorevole di tutta un’epoca. con periodo di
maggior splendore che è andato dal 1845 al 1875.
Un
veliero non grande, stazzante meno di 1000 tonn., lungo poco più di
Il
vecchio Willis aveva voluto dal costruttore quanto di meglio poteva essere
impiegato per imporre la sua bandiera d’armamento sul mare della Cina. Nella
Londra vittoriana s’era venuto a determinare un fatto di costume con il consumo
del tè. L’annuale arrivo del primo carico del tè cinese di nuovo raccolto
primaverile, considerato il migliore (una pianta dava tre raccolti), veniva
pagato bene con un premio di 10 scellini ogni
WESTERN OCEAN PACKET
Il
Capo Horn era stato individuato dal capitano olandese Lemaire nel 1615 ma
rimaneva poco frequentato a causa delle continue tempeste che lo battevano e
dei conseguenti pericoli con l’esito di numerosi naufragi. Nel 1848 venivano
scoperti i ricchi giacimenti auriferi della California, il che favoriva un
nutrito movimento migratorio, senza precedenti, di gente che partiva dalle
coste orientali degli Stati Uniti via Capo Horn verso l’immaginato eldorado
californiano dando molto lavoro agli agenti marittimi che pubblicavano
manifesti reclamizzanti questo o quel veliero. Ne approfittavano gli armatori
americani attrezzandosi per il trasporto
dei passeggeri in cerca di ventura, mettendo in linea navi di buona capacità e
ricettività, che si videro navigare tra il 1850 e il 1870. Esiste una ricca
documentazione iconografica di questi velieri in centinaia di quadri ad olio ed
acquerelli raccolti dal Peabody Museum di Salem (non pochi dei quali recano la
firma di artisti italiani, forse emigrati).
Cessata
per esaurimento la “corsa dell’oro”, s’imponeva il trasporto del grano, che
Le
caratteristiche ambientali e marine delle coste nord-orientali dell’America
bagnate dalla corrente fredda del Labrador avevano favorito una estesa attività
peschereccia con naviglio d’altura rispondente a queste caratteristiche.
Naviglio molto invelato, diviso tra gli “schooner salt bankers” che
provvedevano a salare il pescato sul momento ed i “clippers schooners” detti
anche “Gloucester”, velieri molto veloci che portavano il pescato a terra, agli
stabilimenti ittico-conservieri. Tutti degni di menzione anche perché davano
origine a quelle grandi imbarcazioni sportive progettate per la corsa ed armate
dai più noti magnati americani, lunghe una trentina di metri ed equipaggiate
con un numero d’uomini superiore a quanti si potevano trovare a bordo di un
veliero mercantile molto più grande. Sono nate così la prestigiosa “Classe J” e
La
potente Alaska Packing Company si assicurava il monopolio del salmone che
veniva pescato in grandi quantità nelle fredde acque del Nord-Ovest, inscatolandolo
per un esteso mercato di consumo. Nel 1909 diverse compagnie si univano
nell’Associazione dei Conservieri dell’Alaska acquisendo buona parte dei vecchi
velieri non più impiegabili in lunghe navigazioni, che venivano radunati
annualmente nella cala d’Oakland, dove venivano preparati per la campagna
primaverile imbarcando per quattro mesi gente raccogliticcia di ogni risma e
poco pagata, sbarcata e impiegata nella pesca, con molte perdite di mezzi e di
uomini causate dall’ambiente impervio e climaticamente difficile, ma con
continui rimpiazzi finché nel 1939 fu giocoforza ricorrere ai vapori.
COLONIAL CLIPPER
detto anche WOOL CLIPPER
 Veliero di concezione scozzese della Clyde,
impiegato nel trasporto degli emigranti in Australia, paese in via di sviluppo
dopo la scoperta, nel 1849, dei giacimenti auriferi alluvionali di Ballarat
(Victoria) che innescavano un’economia favorita anche da un’agricoltura
intensiva cerealicola, dall’allevamento del bestiame bovino e ovino con grande
produzione di lana, insieme ad una potente industria e ricche miniere di
carbone simile a quello inglese di Newcastle. Ragione di una consistente corrente
immigratoria culminata nel 1875. Gli armatori inglesi venivano invogliati a
costruire o acquistare velieri adatti, reclamizzati come “corrieri
d’Australia”, in sostituzione dei primi velieri inadeguati e lenti tanto che il
viaggio, via Capo Horn, durava dai 4
ai 5 mesi in condizioni inimmaginabili. Il primo “corriere”, il “Marco Polo”,
partito con 930 passeggeri, batteva in velocità lo stesso piroscafo
concorrente, l’“Australie”. Unità notevoli, con 3 o 4 classi, dalla cabina
singola all’interponte, con servizio viveri notevolmente variato (si
incontravano difficoltà solo per il pane) e scorta viveri in conserva per 6
mesi. Esaurito l’oro, restavano e anzi aumentavano i traffici marittimi con
particolare riguardo all’esportazione del carbone di Newcastle A e della lana
grezza, che abbisognavano di stivatori specializzati. I piroscafi non erano
ancora in grado di competere con i velieri date le grandi distanze e le
difficoltà di carbonamento, sicché le navi a vela crescevano di numero e di
portata (2000 - 3000 tonn.) ricorrendosi per talune anche all’allungamento
dello scafo. Si trasformava in veliero perfino qualche piroscafo.
Veliero di concezione scozzese della Clyde,
impiegato nel trasporto degli emigranti in Australia, paese in via di sviluppo
dopo la scoperta, nel 1849, dei giacimenti auriferi alluvionali di Ballarat
(Victoria) che innescavano un’economia favorita anche da un’agricoltura
intensiva cerealicola, dall’allevamento del bestiame bovino e ovino con grande
produzione di lana, insieme ad una potente industria e ricche miniere di
carbone simile a quello inglese di Newcastle. Ragione di una consistente corrente
immigratoria culminata nel 1875. Gli armatori inglesi venivano invogliati a
costruire o acquistare velieri adatti, reclamizzati come “corrieri
d’Australia”, in sostituzione dei primi velieri inadeguati e lenti tanto che il
viaggio, via Capo Horn, durava dai 4
ai 5 mesi in condizioni inimmaginabili. Il primo “corriere”, il “Marco Polo”,
partito con 930 passeggeri, batteva in velocità lo stesso piroscafo
concorrente, l’“Australie”. Unità notevoli, con 3 o 4 classi, dalla cabina
singola all’interponte, con servizio viveri notevolmente variato (si
incontravano difficoltà solo per il pane) e scorta viveri in conserva per 6
mesi. Esaurito l’oro, restavano e anzi aumentavano i traffici marittimi con
particolare riguardo all’esportazione del carbone di Newcastle A e della lana
grezza, che abbisognavano di stivatori specializzati. I piroscafi non erano
ancora in grado di competere con i velieri date le grandi distanze e le
difficoltà di carbonamento, sicché le navi a vela crescevano di numero e di
portata (2000 - 3000 tonn.) ricorrendosi per talune anche all’allungamento
dello scafo. Si trasformava in veliero perfino qualche piroscafo.
A
partire dal 1876 prendeva piede anche il trasporto del petrolio illuminante
americano, “in cassette” (vale a dire in contenitori di latta sistemati a due a
due in una cassetta), verso l’Estremo Oriente dove nel contempo veniva
collocata, a milioni, una pratica lucerna brevettata. Non esistevano ancora le
petroliere, anche se la prima delle quali concepita e progettata come tale, la
tedesca “Glűckauf”, era comparsa da una decina d’anni, ma era una nave
piccola e una novità che stentava a far testo.

NOVA SCOTIA
Compariva
nel 1880 un tipo di concezione americana, che usciva dai cantieri del
Newbrunswick e del New England grazie al legname degli estesi boschi reperibile
in quelle zone e al basso livello retributivo della manodopera che alternava il
lavoro di cantiere con quello agricolo-boschivo.
Veniva
impiegato prevalentemente nel trasporto del guano cileno e del nitrato peruviano
via Capo Horn. Una trentina di questi velieri compariva, di seconda mano, anche
sotto bandiera italiana.
GOLETTA AMERICANA
L’imporsi
della navigazione a vapore e le crescenti difficoltà d’impiego operativo ed
economico della navigazione a vela, finivano per provocare l’abbandono di gran
parte dei velieri, che rimanevano inutilizzati e relegati in zone e canali
fuori mano punteggiando fittamente il cielo con le loro alberature e pennoni a
secco. Da tempo gli ufficiali e i marinai più valenti avevano capito che il
vento non rendeva più passando dall’altra parte, a quella un tempo disprezzata
della navigazione a vapore, ironicamente definita dagli armatori del “vento
pagato”. Veniva a cessare anche la leggendaria linea del guano surclassato dai
fertilizzanti chimici lasciando ancora in attività, per qualche tempo, tre
velieri con bandiera cilena. Da ricordare tuttavia il trealberi “Tusitala” del
1883, armato a vele quadre, a nave, il cui ultimo utilizzo veniva procrastinato
fino al 1932.
Un
estremo tentativo di mantenere il traffico a vela veniva fatto dalla marineria
del Maine con il ricorso all’attrezzatura a randa, proprio delle golette,
richiedente pochissimi uomini e distribuita su più alberi, da servire al
cabotaggio perché poco adatta alla navigazione d’altura, specialmente nella
zona meridionale delle tempeste. Di questo ultimo tipo comparso nel 1880, molto
insellato, si sono contate 460 unità a 4 alberi,
CARRIER
Veliero
di concezione inglese, adottato anche dalla marineria francese, tedesca e
italiana, con scafo in ferro di grande capacità di carico grazie ad una carena
di forma appiattita, non essendo più richiesto il fattore velocità. Era munito
al centro nave di un cassero sul quale, togliendolo dalla pericolosa stazione
dell’estrema poppa, era stato trasferito il timone, unito al casseretto di
poppa e al castello di prua per mezzo di un leggero ponte volante, che
consentiva lo spostamento degli uomini al riparo delle ondate che frangevano
in coperta. Impressionante restava la selva delle manovre fisse e volanti e il
gran numero dei bozzelli che battendo sugli alberi e sui pennoni metallici
producevano un gran clangore. Attivo tra il 1890 e l’ultimo periodo velico,
macchina complicata ma perfetta, il carrier ha rappresentato il tipo non più
suscettibile di evoluzione con cessione finale del passo alla navigazione
meccanica.
Caratteristici
i grandi quattro alberi con alberatura meno alta e vele più equilibrate e
manovrabili, tanto da consentire una diminuzione dei marinai, ma più lenti e
difficili a far virare di bordo, causa questa di molte delle perdite subite. Il
fattore velocità, essenziale come si è visto all’epoca della guerra dell’oppio
e della gara del the, aveva perduto il suo valore e i ritardi erano talora
volontari perché, per certi articoli, quanto più la merce stava a bordo, tanto
più diminuivano le spese di magazzinaggio a terra.
Curioso
il fatto che questi velieri inglesi venivano ironicamente soprannominati “lime juicers” per il fatto che, in base
ad una disposizione di legge, doveva venir somministrato giornalmente agli
equipaggi del succo di limone quale presidio antiscorbutico (in realtà non
efficace).
La
prima guerra mondiale 1914-18 segnava inevitabilmente la fine a breve termine,
preannunciata da tempo, della plurisecolare attività velica, che arrivava
all’ultimo suo atto con manifestazione di altissimo impegno e maestria
professionale, non più eguagliata. Rimanevano ancora un armatore (Erikson) e
singoli velieri adibiti a navi scuola con limitato impiego commerciale, non
rinunciandosi ancora a quella forma di educazione che ancor oggi è riconosciuta
alla vela.
Curioso
ed unico il fatto del veliero “Seeadler” battente bandiera tedesca che, al
comando del conte Felix von Luckner, ha operato come nave corsara
nell’Atlantico e nel Pacifico, in alto mare. Merita citarne la singolare e
avventurosa attività. Il trealberi americano “Pass of Bahama” era diretto ad
Arcangelo con un carico di cotone ma, fermato da un incrociatore inglese,
veniva dirottato su Kirwall con alcuni inglesi di guardia. Fermato poco dopo da
un sommergibile tedesco, il carico di cotone veniva dichiarato buona preda e il
veliero condotto a Cuxhaven. Si decideva a Berlino di impiegarlo come nave
corsara in considerazione del fatto che la navigazione a vela non comportava
problemi di autonomia. Rimorchiato a Grestemuende, nel cantiere di Tecklenbord,
subiva accuratissimi lavori di adattamento con armamento camuffato facendo
circolare la voce che lo si voleva impiegare come nave scuola col nome di
“Seeadler”, per cui veniva munito plausibilmente anche di un motore da 1000 HP.
Gli spaziosi locali per gli allievi erano destinati, in realtà, agli equipaggi
delle navi affondate fatti prigionieri. Un ingombrante carico di legname veniva
sistemato in coperta per rendere difficoltose le possibili visite al passaggio
del blocco continentale inglese. A tal fine si preparavano anche carte di bordo
false riguardanti il veliero norvegese “Maletta” che si venne a sapere fermo
per lavori a Copenhagen e diretto a Melbourne. Venne imbarcato un equipaggio
scelto di 64 uomini tra i quali molti parlavano il norvegese sennonché quel
nome, ad un certo momento, non andava più bene dovendosi sceglierne un altro,
l’”Irma”. Il 21 dicembre 1914 segnò la partenza e grazie anche ad una violenta
tempesta, la singolare nave corsara ebbe modo di passare la linea di blocco
dopo aver subito una visita inglese a bordo. Entrava in Atlantico girando molto
al nord, scendeva al sud fino al passaggio del Capo Horn, che doppiava con
grande difficoltà mettendoci tre settimane e mezza, ed entrava finalmente in
Pacifico. L’attività bellica del corsaro fruttava l’affondamento di tre
piroscafi e di otto grandi velieri, più un veliero catturato e lasciato libero
con 263 prigionieri che non si potevano tenere. Si faceva sentire il problema
della fine dei viveri e dell’acqua per cui il “Seeadler” doveva poggiare
sull’isola di Mopalia (arcipelago della Società) dove fu possibile un’attività
di caccia e pesca. Ma qui succedeva l’imprevedibile. Un terremoto sottomarino
provocava una grande onda anomala che investiva il veliero con violenza tale da
alzarlo e spingerlo sulle rocce coralline che provocavano uno squarcio nella
carena e l’abbattimento dell’alberatura. Era accaduto che il motore, con i suoi
1000 HP inutili, non s’era messo tempestivamente in moto per salvare l’unità.
Dalla quale fu sbarcato tutto quanto poteva essere salvato, radio compresa.
Bisognava cercare di uscire in qualche modo da quella situazione e il
comandante von Luckner munì il motoscafo di bordo con una vela prendendo il
mare con 6 uomini armati al fine di catturare qualche naviglio adatto per il
salvataggio comune. Battezzava il piccolissimo “motoveliero corsaro”
“Kronprissezin Cőcilie” con il quale percorreva
I VELIERI ITALIANI
I
grandi velieri oceanici italiani, di ferro, a quattro alberi, non sono stati
molti, circa una decina, però splendide unità che hanno fatto un buon servizio,
sette dei quali di progettazione e costruzione nazionale, precisamente ligure.
I trealberi, invece, sono stati numerosi.
Meta,
Piano di Sorrento e Sant’Agnello sono stati i centri maggiori d’armamento dell’Italia
Meridionale con le Case Ciampa, Lauro, Trapani, Cafiero, Argarita, Mastellone,
Pollio, Esposito che hanno armato oltre 60 velieri, la metà dei quali impiegati
nel Pacifico non riuscendo a reggere però alla crisi della prima guerra
mondiale.
Procida
e Gaeta hanno messo in mare, con le Case D’Abundo e Scotto Lachianca, una
decina di velieri ma è con le liguri Nervi e Quinto con i loro 25 velieri
moderni, con Genova Recco e Varazze, con le Case Milesi e Cerruti che il numero
sale. Camogli armava numerosi velieri in legno e da ultimo oltre
“Fratelli
Beverino”
Varato
nel 1882 col nome di “Glenorchy” dalla Glen Line di Glasgow, passava alla Casa
Beverino che nel 1909 lo vendeva a Gioacchino Lauro passando in Pacifico col
nome “Cavaliere Lauro”. Passato infine col nome “Italia” all’armatore Esposito
di Meta, di ritorno dal Cile con un carico di nitrato veniva investito da un
piroscafo e affondava in pochi minuti.
“Emanuele Accame”
È la
nave a palo più famosa e longeva di Loano, attiva su tutti gli Oceani. Varata a
“Augustella”
Costruito
a Glasgow nel 1892 col nome di “Jordanhill”, veniva acquistato dalla Società Stella
d’Italia, venduto presto in Spagna, dove, dopo molti anni di navigazione,
finiva alla demolizione nel 1937.
“Balmoral”
Varato
nel 1892 per la bandiera britannica, passava nel 1911 all’Italia acquisito dai
Milesi ponendosi tra i più grandi e meglio attrezzati velieri nazionali.
Tornava in Italia con un carico di nitrato dopo una lunga campagna in Pacifico,
riprendeva la navigazione per Baltimora quando, a guerra inoltrata, sorpreso da
un sommergibile germanico in un momento di calma piatta, veniva affondato a
cannonate, e
“Edilio
Raggio”
Varato
a
Varato
nel 1903 dal Cantiere della Foce di Genova per
“Gabriele
D’Ali’”
Fu
un’ottima unità della Casa D’Ali’ di Trapani, il veliero più grande tra gli
armatori meridionali, varato nel 1903. Passato indenne tra i pericoli della
guerra, veniva demolito a Trieste nel 1923, ultima nave a palo della flotta
velica commerciale italiana.
“Erasmo”
Varato
a Riva Trigoso nel 1903 per conto degli armatori Raffo e Bacigalupo di
Chiavari, fu unità veloce collezionando primati malgrado le molte tempeste
nelle quali ha avuto la ventura d’incappare, in Atlantico e nel Pacifico.
Venduto alla Casa tedesca Laeisz, navigava col nome di “Pinguin” e veniva
demolito nel 1923 dopo aver alzato anche la bandiera francese.
“Regina
Elena”
Armato
da Casa Milesi di Genova, veniva varato a Riva Trigoso nel 1903. Allestito con
cura sotto la sorveglianza di capitani esperti, condotto in campagne effettuate
con passaggi veloci e con carichi di vario genere non escluso il nitrato
peruviano e il petrolio in cassette, nel 1912 veniva ceduto alla Casa Laeisz
col nome di “Ponape”. Catturato dagli inglesi durante la prima guerra mondiale,
navigava col nome “Bellhouse” passando poi sotto bandiera norvegese fino al
1927.
“Italia”
Con
la sua portata di 4.200 tonn., è stato il più grande veliero costruito dai
cantieri nazionali. Varato al Muggiano nel 1903 per conto degli armatori
Cavalieri Becchi e Sturlese di Genova, attrezzato a nave a palo con i ritrovati
più recenti, con 18 vele quadre, randa e 12 vele triangolari, albero maestro di
La
navigazione a vela oceanica italiana si chiudeva con il quattroalberi “Patria”,
l’ex tedesco “Susanne Vinnen” (Brema, 1922), entrato in servizio nel 1932 come
nave scuola per l’addestramento degli aspiranti al comando di navi mercantili,
con istruttori messi a disposizione dalla R.Marina, essendo armatrice
Un
cenno anche al trealberi “Giorgio Cini”, nave scuola della Fondazione Cini, con
base all’Isola di San Giorgio di Venezia, adibito a crociere d’istruzione per
gli alunni degli istituti nautici. Uscito nel 1896 dagli Ances Cantiers
Dubignaon di Nantes col nome “Belem”, cambiò proprietà e nome più di una volta,
anche riclassificato in yacht, con bandiera francese, inglese e italiana
quando, nel 1951, veniva comperato dal conte Cini sottoposto, due volte, a
lavori di riclassificazione con cambiamento dell’attrezzatura velica.
Nell’estate del 1980, dopo un periodo di sosta, tornava alla bandiera francese
per essere ripristinato a cura di una società di shiplover riprendendo il nome
di “Belem” con base a Nantes dove tutt’ora si trova
AUSTRIA UNGHERIA
Non
sarà fuori luogo ricordare qui anche
Non
è stato questo il solo lutto lamentato nei mari del Sud dalla marineria velica
battente bandiera austriaca. Tra il luglio e l’agosto del
Batteva
la stessa bandiera anche il veliero a quattro alberi, tutti a vele quadre,
“Francesco Giuseppe I°”, ex britannico “Falls of Afton”, che può essere considerato l’unità più
grande della flotta veliera di quella marina.
ARMAMENTI ESTERI
La
vela scandinava, inizialmente molto forte, formata tutta da velieri ex inglesi,
entrava in crisi con la guerra del 1914, ma tuttavia, nel 1918, contava ancora
126 velieri norvegesi, 13 danesi, 7 svedesi, 21 finlandesi.
Figura
di primo piano era l’armatore finlandese Gustav Erikson, un innamorato della
vela fino all’ultimo suo respiro. Prendeva imbarco in giovanissima età come
cuciniere, a 17 anni era già promosso marinaio, percorreva la carriera
professionale fino alla patente di comandante abilitato al lungo corso
navigando per più anni. Acquistava durante la prima guerra mondiale il suo
primo veliero, una vecchia unità russa, facendosi intraprendente armatore
favorito dagli alti noli di quel periodo. Acquistava via via altri velieri, la
crisi del 1921 non lo scoraggiava e nel 1924 si impegnava nel trasporto del
grano australiano in una nuova ma ultima gara con 3 svedesi e 3 tedeschi
sollevando un notevole interesse di stampa, che però non durava molto. Nel 1939
alzava la sua insegna armatoriale su 14 grandi velieri d’acciaio, 3 navi
ausiliarie a motore, 3 piroscafi da carico e 3 motonavi. Gestiva tra l’altro i
noti quattroalberi ex germanici “Pamir”, “Passat”, “Penang” e “Pommern”
mantenendo le rotte del grano grazie ad una particolare organizzazione in
regime di grande economia, osservata anche personalmente, con atterraggi in
zone dove i piroscafi non potevano arrivare, con trasbordi assicurati da
piccoli navigli locali. Durante la seconda guerra mondiale il “Pamir” e il
“Lawhill” venivano requisiti dagli alleati a Wellington e a Capetown, altri
suoi velieri venivano affondati. Il “Pamir” tornava in Europa nel 1947 sotto
bandiera neozelandese con carico completo di grano e finiva per passare
nuovamente sotto bandiera tedesca. Restavano ancora due velieri naviganti e
tre in disarmo per vetustà.
Alla
fine del 1938 esisteva ancora una cinquantina di navi a vela, 20 delle quali
dell’Erikson, ormai sulla via del disarmo.
FRANCIA
La
moderna flotta francese a vela si sviluppava relativamente tardi grazie alla
riforma lungamente invocata delle norme governative finanziarie e doganali, la
riorganizzazione e modernizzazione dei cantieri navali di Dunkerque, Nantes,
Bordeaux, Saint Nazaire, Le Havre, della Seyne con conseguente entrata in
servizio di 300 grandi navi.
Venivano
armati a Nantes, dal 1895 al 1905, oltre 150 velieri in prevalenza MEDIUM
CLIPPERS, velieri impiegati sulle linee della California, dell’Australia, del
Cile dei quali, dopo la guerra, non ne resteranno che una ventina.
L’armamento
principale portava la bandiera di Antonin Dominique Bordes , che aveva iniziato
il suo straordinario curriculum giovanissimo nel 1834 quale agente in Cile di
un armatore di Bordeaux, divenendo poi suo socio, finché rientrava in Francia
nel 1867. L’apertura del canale di Suez veniva preconizzato dai più come
foriero della morte della navigazione a vela, ma non per Bordes che investiva
tutte le sue ricchezze nell’acquisto di velieri da adibire al trasporto del
nitrato cileno diventando il primo armatore su piano mondiale. Morto egli nel
1883, l’attività veniva continuata dai suoi tre figli che la incrementavano
tanto da armare una flotta di cui facevano parte 98 grandi navi a palo
cap-horniere.
Louis
Lacroix racconta che Antonin Bordes si trovava, un giorno, insieme al suo
capitano Eugène Voisin a bordo del veliero a quattro alberi “Dunkerque”,
costruito nel 1888 e considerato un gigante per quell’epoca. L’armatore gli
confidava che intendeva costruire un veliero ancora più grande, con portata di
non meno di 6000 tonn., al che il capitano gli faceva presente che ciò non era
possibile in quanto si era già giunti al massimo che gli uomini potevano
ragionevolmente tenere sotto controllo e manovrare. Bordes non era di questo
parere dichiarando che non si doveva far altro che allungare lo scafo e
aggiungere un albero in più senza bisogno di aumentare le misure della pesante
attrezzatura velica. Così fu infatti fatto e nasceva il “France” (I°) commissionato nel 1889 ai cantieri inglesi
Henderson di Partick presso Glasgow, con scafo in acciaio lungo
Caratteristica
della Casa Bordes era la pitturazione degli scafi, grigia in basso con una
fascia superiore bianca scandita da prua a poppa da una fila di false
cannoniere nere. Inoltre, se i vapori consumavano carbone, i velieri
consumavano vele per cui il vecchio Bordes adottò una soluzione razionale
alzando vele della stessa precisa misura su tutti gli alberi e su tutti i suoi
velieri in maniera da renderle rapidamente intercambiabili con guadagno di
tempo e di spese.
La
guerra fu esiziale per
Batteva
il mare, nel 1913, un secondo “France” varato dai Cantieri della Gironda di
Bordeaux su progetto dei noti costruttori Prestant, Leblond, Leroux e Heuzeg
per conto della Società Anonima delle Navi Miste, attrezzato con quanto di
meglio si trovava all’epoca. Capace di un carico di oltre 8000 tonn., lungo
GERMANIA
La
vela è stata tenuta dai Tedeschi in gran conto quale plasmatrice di carattere
e fornitrice di cognizioni utili anche alla marina moderna sicché molti degli
armatori di velieri hanno procurato di distinguersi nella cura delle
attrezzature e nella disciplina della gestione come elemento distintivo di
bandiera tra le flotte che battevano il mare, con scelta oculata di navi
dimesse inglesi (e alcune anche italiane) e navi di costruzione nazionale.
Armamenti principali le Case Laeisz, Rh vom 1896, Knohr e Burchardt, Rickmers,
Vinnen, Schluter e Mack.
Verso
il 1880 si costruivano a Flensburg alcuni velieri in ferro ma il primato
passava presto ad Amburgo e Brema, con 97 e rispettivamente 41 unità.
Bisognava
sostituirla con un’altra unità e, in attesa di poter valutare le prestazioni del
“Potosi” di Laeisz, acquistava due quattroalberi inglesi. Poi, nel 1906,
Il
trealberi a vele quadre “Rickmer Rickmers” di 1800 tonn., varato nel
Restano
ancora il quattro alberi “Padua”, passato come nave scuola alla marina
sovietica col nome “Kruzenshtern”, il “Falls of Clyde”, il “Moshulu”, oltre
alle navi scuola militari, come l’italiana “Amerigo Vespucci”, che per le loro
caratteristiche fanno capitolo a sé.
COMMIATO
Si è
fatto cenno alle rotte del guano e del salnitro, principale attività degli
ultimi velieri che arrivavano alle semideserte coste occidentali dell’America
Latina, sostando talora numerosi e a lungo nei posti di caricamento di
Coquimba, Taltal, Antofagasta, Mejillones, Iquique, Pisagua. Si è fatto cenno
anche alle tradizioni e ai riti osservati dagli equipaggi con grande
partecipazione degli uomini di tutte le bandiere in una comunanza
ultranazionale, trasversale, che è degna di essere richiamata quale
manifestazione di reciproco considerazione e rispetto. Quando una nave,
completato finalmente il carico, stava per tornare in patria dopo una campagna
durata uno o due anni, tutti facevano festa.
Ecco
come il capitano Mario Taddei, imbarcato allora sul trealberi “Saturnina
Fanny”, ricorda l’evento con l’immedesimazione di chi ha vissuto quei momenti.
“Pronti
a partire? No, quasi pronti. Insomma, al punto di fare gli hurra! Questi hurrà
dati e presi, dati dalla nave che parte; dati, una ad una, a tutte quelle che
restano, e restituiti singolarmente da queste, secondo una rigida formula
tradizionale, anche se non ancora scritta in alcun protocollo.”
(Viene
preparata intanto una curiosa luminaria formata da due pennoni legati in croce
con quattro fanali, due bianchi e due rossi)
“Nel
silenzio, nella tenebra, nella placida serenità della notte tropicale, sul
porto che gode la sua pace oscura scroscia improvviso lo squillo bronzeo della
nostra campana… La campana tace. Chi dà la voce è John, il norvegino. Lui sa
l’inglese meglio degli altri… tutti lo capiscono. John dà la voce perché tutti
diano ad un tempo lo strappone sul cavo che tiene i quattro fanali in croce: Un
uomo solo con quattro bracciate li porterebbe facilmente a segno. Lì sono venti
uomini che ritmano le strappate simboliche, tutti insieme, ripetendo in coro il
ritornello come dovessero issare una gabbia, e ci mettono mezz’ora. È il rito”
“Il
grido gutturale di John scandisce dei versetti vuoti di lirica… ma i suoi
versetti sono pieni di significato… I quattro fanali toccano lo strallo di
trinchetto… È l’ora dell’addio da gridarsi a gran voce. È dalla dritta che si
comincia… La campana squilla a distesa per qualche istante… Una voce grida alla
nave più vicina, l’ “Almendral” francese:
— Three cheers to the “Almendral”!
e la
gente in coro:
— Hip, hip, hurrà! Hip, hip, hurrà! Hip, hip, hurrà!
“Silenzio.
“Risponde
la campana dell’ “Almendral”, ed altre voci rispondono nella tenebra lo stesso
triplice saluto.
“Un
altro Hip, hip, hurrà! da parte della “Saturnina Fanny”
“Segue
poi, nella notte ormai alta, l’appello e il saluto marinaro attraverso lo
spazio, nella rada immensa. Sul castello di prora i nomi si succedono, sono
ripetuti, a memoria, con sicurezza assoluta… Rispondono tutti. Hanno risposto
tutti. Precisi, impeccabili. Grave sarebbe il non rispondere. Non si è mai dato
questo caso… La grande croce con i quattro fanali rossi e bianchi viene
ammainata lentamente… La campana squilla di nuovo. Lungamente. Quando tace, da
ogni nave, dalle più vicine sino a quelle ancorate negli angoli più remoti
della rada, è un rispondere sonante e simultaneo di altre quaranta campane di
prora. Gettano nello spazio i timbri più diversi di bronzi fusi nei cento
cantieri d’Europa…
“Danno
un addio e un augurio concorde alla nave in partenza… Infine il silenzio
ritorna con le ultime eco lontane dalle rupi della costa”.
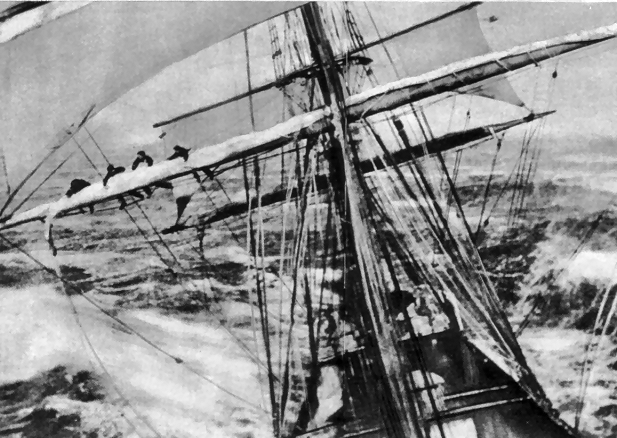
NOTA BIBLIOGRAFICA
La
letteratura storica, memorialistica e di evasione o di intrattenimento è tanto
ricca da non poter rientrare in una nota bibliografica riguardante un lavoro
compendioso e ristretto come il presente che rispecchia quanto pubblicato solo
da 10 scrittori. Men che meno la letteratura tecnica.
Si
citano gli inglesi Alan Villiers, Francis Chichester, W.H.S.Jones, Robert L.
Stevenson; gli americani Fred. B. Duncan, Richard H. Dana Jr., Herman Melville; i francesi Armand Hayet, Louis
Lacroix; il tedesco Felix von Luckner; gli italiani Tomaso Gropallo, Mario
Taddei, Flavio Serafini, Claudio Ressmann, Vittorio G. Rossi. Quasi tutti hanno
vissuto e navigato sui velieri d’alto mare raccogliendo documentazioni di prima
mano.
Vanno
ricordati anche gli scrittori Jack London e Joseph Conrad (il polacco
naturalizzato inglese Konrad Kozeniowski) che ha navigato anche su velieri
italiani.
Per
quanto riguarda le navi scuola, vedi i quaderni AMA N° 57/93 “Navi scuola a
vela nella Marina italiana dal 1863 ad oggi. Militari e mercantili” di Piero
Comuzzi, e N° 42/87 “La nave scuola “Beethoven” (1913-1914)” di Aldo Cherini.
Notabile
ed splendidamente illustrato il lavoro di Italo Ottonello “Le vecchie
canzoni dei giorni dei velieri — Alla ricerca delle grandi tradizioni di vita e
cultura del mare”, Supplemento alla Rivista Marittima 11/2011
|
|
|
|
NOTE
1) L’”East India Company” perdeva il monopolio
del the nel 1833 e prendeva l’avvio un rinnovo che interessava anche il vettore
navale. La risposta cantieristica inglese non era inizialmente molto felice con
unità non molto veloci, dette FREGATE
DI BLACKWALL dal cantiere Green e
Wigram che le costruiva, caratterizzate da un notevole slancio di prua, ma il
cantiere di Alexander Hull e Son di Aberdeen (Scozia) non appariva impreparato
varando unità, gli ABERDEEN CLIPPER, via via migliorate riguadagnando il tempo
perduto, con tonnellaggi crescenti.
2) Le costruzioni in ferro non incontrarono
inizialmente molto credito non esistendo ancora prodotti siderurgici pienamente
affidabili. Ebbe più successo la costruzione degli scafi composita, o mista,
brevettata nel 1850 da John Jordan di Liverpool. Maggiore la robustezza, ma
maggiori anche i costi e i danni provocati nelle strutture metalliche dalle
correnti galvaniche
3) Nati dalle necessità della guerra del Nord
America contro gli Inglesi, con doti di velocità e stabilità di avanguardia,
forme di scafo assai stellate, venivano adottati stabilmente crescendo di
dimensioni. Si può considerare come
antesignano l’inglese “Falcon”
costruito nel
Il
successo era immediato, pur con l’inconveniente di legnami non di prima qualità
e non ben stagionati (a differenza delle costruzioni inglesi). Emergeva il
progettista Donald Mac Kay, autore di velieri detentori di primati, come il
“Lightning” (1853). Il boom americano aveva però breve durata con la crisi che
portava nel 1857 alla guerra civile tra gli stati del Nord e del Sud.
Dopo
il 1850 si dedicavano alla costruzione dei clipper tutti i migliori cantieri
inglesi, Alexander Stephen di Kelvinhaught, Beniamin Nicholson sul fiume Annan,
George Cox sul Tamigi, con progettisti quali John e William Pile, William
Rennie.
4) Col termine “packet” (traducibile in
postale) si intendeva il clipper
impiegato per il trasporto (non esclusivo) dei passeggeri tra i porti
dell’Europa e delle Americhe in classi di cabina e di ponte, questa assai
spartana. La gestione era generalmente di appannaggio delle società americane
“Black Ball Line”, “Slawllow Tail Line” e “Red Cross Line”. Era molto noto per
le sue traversate primato il veliero “Dreadnought” di 1400 tonn.(1853) degli
armatori Morgan Cutting Ogden. Andava perduto nel 1869 al Capo Horn non a causa
di una delle tante tempeste della zona ma per la improvvisa caduta del vento
che lo lasciava in balìa delle correnti che lo portavano contro le rocce della
costa.
5) La scoperta dell’oro australiano e la forte
corrente immigratoria attiravano l’interesse degli armatori che dirottavano i
clipper del the oltre ai velieri armati allo scopo, primo dei quali l’”Eagle”
del 1853. Il più noto degli armatori era James Baines della “British Black Ball
Line” (da non confondere con la “Black Ball Line” americana) che metteva in
linea 86 velieri tra i quali il “Marco
Polo”, seguito dalla “White Star Line” di Thomas H.Ismay e la “Red Cross Line”
dei fratelli Fernie con un altro veliero molto noto, il “Torrens”. Nei viaggi
di ritorno veniva caricata la lana, che veniva compressa con martinetti a vite,
tanto che il “Mermerus” riusciva ad imbarcare 10.000 balle per un valore di
132.000 sterline. Fenomeno tipicamente inglese.
6) Il “Saturnina Fanny”, di 1594
tonn., faceva coppia con l’“Australia”. Uno dei migliori clipper a tre alberi,
costruito nel 1891 nel cantiere Odero di Sestri Ponente su progetto dell’ing.
Fabio Garelli e dell’architetto Tappani per l’armatore Giuseppe Bacigalupi di
Chiavari. Proveniente da Rosario per Genova, giunto al largo di Barcellona,
veniva affondato da un sommergibile tedesco il 22 maggio 1916.